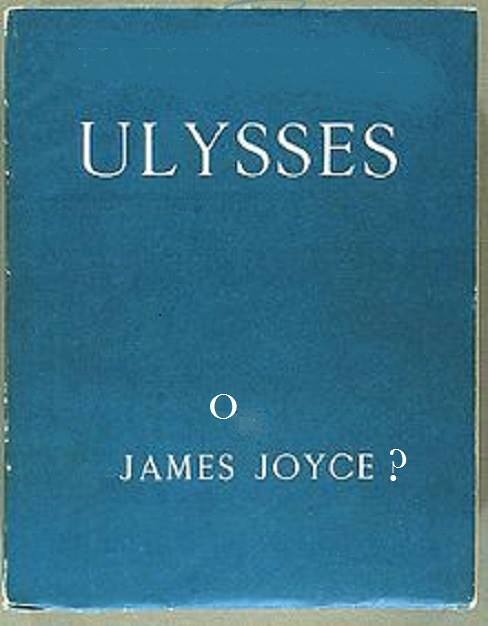Recensioni
Ulysses o James Joyce? (Woolf, Lacan, Derrida – su Joyce)
a cura di Lisa Orlando
“Sono rimasta confusa, annoiata, irritata e delusa da questo liceale a disagio che si gratta i foruncoli. E Thomas (Eliot), il grande Thomas, lo mette sullo stesso piano di Guerra e pace! Per me è un libro ignorante, plebeo; il libro di un operaio autodidatta…”, scrisse Virginia Woolf dopo aver letto le prime duecento pagine dell’Ulisse. Al di là dell’aspra critica woolfiana, ciò che apparve lapalissiano sin da subito fu la speciale, rivoluzionaria indecifrabilità della scrittura che differì Joyce da tutti gli altri scrittori. Indecifrabilità ch’era (ed è) gigantesca folle risata che Joyce affondò (e affonda) nell’abisso dell’assurdo l’atto stesso dello scrivere?
In modo del tutto differente, a spiegare l’operazione di scrittura joyciana (contribuendo pur a una ulteriore salvazione della stessa) ci provarono due studiosi; un filosofo: Jacques Derrida e uno psicanalista: Jacques Lacan. Per comprendere e dimostrare la potenza speciale della parola di Joyce, entrambi impegnarono il loro sofisticato intelletto in una rigorosa analisi, per alla fine dichiarare che Joyce è l’assoluto!; è il solo scrittore – che ha al massimo potenziato le risorse dell’equivocità linguistica; equivocità espressa in un linguaggio che lasciò affiorare (nella più grande sincronia possibile) la massima potenza delle intenzioni raccolte nell’anima di ogni atomo linguistico, di ogni vocabolo, di ogni parola, di ogni proposizione semplice.
Sia Derrida che Lancan constatarono (ampiamente) un’abile superiorità dello scrittore irlandese, che consisteva nella superba sicurezza con cui Joyce si pose e si impose come autore e autorità insieme. Fin dall’ inizio, Joyce, con volpina trappoleria, rivendicò per sé una immortalità in opposizione alla pedante osservanza di canoni accademistici. ; e non v’ è alcun dubbio che l’abbia portata a compimento. In questo senso, sostenne Derrida, Joyce non fu affatto un idealista, ma uno scaltro calcolatore. Se è vero come è vero (e Joyce lo intuiì presto) che lo scrittore nasce dopo l’opera, e che è a partire dal libro che esiste lo scrittore, Joyce fece in modo che il libro che scrisse dovesse essere assolutamente “indecifrabile”, piegando nei secoli a venire tutti gli accademici, i quali non solo andranno (nel tempo) ad alimentare il suo egotismo, ma omaggeranno nel libro che distrugge la lingua, la più imponente sfida che uno scrittore abbia lanciato contro di sé, contro la significazione tutta.
Ma cosa vuol dire leggere Joyce? Derrida rivelò: «Ogni volta che scrivo su Joyce un suo fantasma improvvisamente mi assale»; è l’autorevole macchina di lettura, con tanto di firma e controfirma al servizio del suo nome, che grazie alla propria opera Joyce ha fabbricato. Si potrebbe ipotizzare che sia quel brevetto che, probabilmente, fa invidia a Derrida. Invidia per una capacità di preparazione e realizzazione di un progetto universale della propria opera che, forse, a livello della filosofia universitaria, Derrida stesso ha cercato di compiere? Anche Derrida, di fatto, ha spinto fino alle estreme conseguenze le facoltà dialettiche, logico-razionali, lasciando girare al massimo delle sue capacità il motore della logica. Derrida, tra l’altro, non sente di poter amare totalmente Joyce; la sua ritrosia è causata dall’atteggiamento dello scrittore irlandese, che ha posto noi lettori in una condizione di debito infinito. Chi può dire, infatti, di aver letto con serietà, e per davvero i suoi libri?
Nel caso di Lacan, invece, cosa comprese di Joyce? Come lo lesse? Lui, innanzitutto, si chiese per quale motivo Joyce scrivesse. Per Joyce scrivere fu un sintomo; ma per “sintomo” Lacan non intendeva un abbandono, un impedimento. Riprese piuttosto la parola secondo l’antica grafia francese e la scrisse in tal modo: sinthome, perché nel pronunciarla sfumasse in saint’ homme, evocando intenzionalmente nel suono la parola “sant’ uomo”. Se è un sant’ uomo, Joyce, è perché in tutta la sua opera Lacan intravide il munifico sforzo di affrancarsi della carenza del padre. Lacan espose una verità che noi, appassionati di Joyce, avevamo colto a livello tematico: non avevamo alcun dubbio che l’Ulisse fosse testimonianza del fatto che Joyce si fece carico del problema del padre, e in quel rapporto restò imprigionato, pur rinnegandolo. E avevamo letto questo come il suo sintomo. Tuttavia, non avevamo operato l’ulteriore passaggio e che Lacan, invece, ci fa fare: e cioè, che se Joyce si salva, è perché Joyce, conformemente agli iniziali propositi, riuscì a fare di se stesso (nella pur sfibrante fatica) un libro. E Joyce si “fece” libro uccidendosi, trattandosi come puro oggetto, un organismo che ebbe per caso un nome umano, e a cui sottrasse tutto il suo sangue – per l’eternità!
Utenti on-line
Ci sono attualmente 17 Users Online